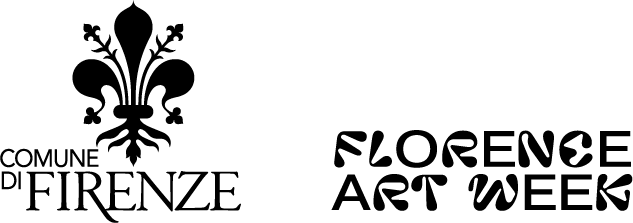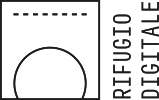INVASION DRAMA
Roberto di Caro
dal 16 settembre al 15 ottobre 2022 | Mer – Dom 11.00 – 19:00

Gallery Notice : Images have either not been selected or couldn't be found
© Lorenzo Prodezza
Dal 16 settembre 2022 Rifugio Digitale ha ospitato Invasion Drama, mostra fotografica dell’inviato del settimanale L’Espresso Roberto Di Caro, a cura di Laura Andreini. Un racconto delle guerre in Afghanistan e Iraq dal 2001 al 2009, un diario di viaggio tra speranze, rabbia, rassegnazione, attraverso immagini dal fronte, scritti, reperti e musiche. Con due testi di Franco Farinelli, insigne geografo, e Uliano Lucas, decano della fotografia italiana di reportage. Negli scatti scorre una quotidianità difficilmente immaginabile: un Afghanistan senza pace da decenni, i mujaheddin al fronte, la resa della roccaforte talebana di Kunduz, i combattimenti contro Al Qaeda in Kurdistan, la frenesia del ritorno alla normalità nell’Iraq dopo la caduta di Saddam, gli attentati a Baghdad. Dietro ogni volto c’è una storia, una ferita, un riscatto. Il tentativo è mostrare anche l’altra faccia di conflitti fatti non solo di kalashnikov e carri armati, ma di persone, vita ordinaria, bambini, donne e uomini in territori distrutti dalle bombe in guerre che sembrano non avere fine. Mettendo a confronto due realtà, Afghanistan e Iraq, facendole dialogare su vari temi, nomadismo, guerra, città, archeologia e altri. Per dar conto delle complessità e contraddizioni di conflitti di cui troppo spesso sfuggono le coordinate, le ragioni, le possibili vie d’uscita. Situazioni irripetibili vissute dal reporter, un lavoro di quasi un decennio sviscerato e racchiuso nello spazio di Rifugio Digitale.
Vita e Fotografia, Uliano Lucas
Una fotografia può vivere molte vite. A seconda di chi la guarda, del tempo trascorso dallo scatto, forse soprattutto del modo in cui viene mostrata all’osservatore. È quanto succede a queste immagini, scattate da Roberto Di Caro ormai un ventennio fa durante le sue corrispondenze giornalistiche per L’Espresso dalle polveriere del nuovo millennio, Afghanistan, Kurdistan, Iraq, protagonisti di conflitti complessi che avrebbero ridisegnato lo scenario geopolitico degli anni successivi. Nascono come appunti di un giornalista di penna che ama la fotografia e annota coi suoi scatti impressioni di un mondo lontano e difficile: incontri, sensazioni, contraddizioni, realtà di guerra e momenti di vita quotidiana. Non sono pensate per essere pubblicate, possono permettersi di non costruire un racconto, di non dare la notizia, di non fare sensazione, come sempre più spesso richiesto alle fotografie dai teatri di guerra.
Utilizzate talvolta all’epoca per accompagnare gli articoli e poi rimaste nascoste per anni tra i materiali di lavoro del giornalista, scoprono oggi nuove modalità di diffusione e nuove funzioni. Ci parlano e interrogano in modo nuovo. Nel 2019 una mostra tenutasi a Bologna e un libro le intreccia a frammenti di articoli e lettere, costruendo attraverso un intelligente dialogo tra parole e immagini un affresco delle realtà dei paesi visitati, facendo emergere un comune modo di narrare, che procede per pennellate, descrizioni intense e sintetiche di una realtà, incisive, coinvolgenti e prive di retorica. Il racconto giornalistico diventa racconto letterario, accompagnato dal controcanto visivo di fotocolor ormai sbiaditi dal tempo.
Il nuovo montaggio filmico delle foto qui proposto ci porta ancora su un altro piano comunicativo, ci parla con il linguaggio dell’empatia e della immedesimazione, aprendo le fotografie ai viaggi della nostra immaginazione. Il racconto perde in informazione e si arricchisce di pathos. Attraverso molteplici esplorazioni all’interno di una foto, zoomate e carrellate che un tempo si ottenevano con la truca cinematografica e oggi con il video-editing digitale, si compie un percorso dentro l’immagine che scopre altre foto dentro la foto, volti, espressioni, paesaggi, dettagli. Un sapiente lavoro di rielaborazione filmica del fotogramma ragiona sugli spazi, sulle luci, sulle azioni presenti in un’immagine facendo emergere luoghi e situazioni prima passati inosservati, dando alla foto il dono del movimento. È una reinvenzione della foto, un racconto che non ha più bisogno del testo per essere completo, ma vive di vita propria, trasportandoci accanto al fotografo dentro i luoghi da lui vissuti, tra paesaggi impervi e popolazioni lontane per cultura, mentalità, economia.
La distanza storica da quanto è successo permette una ridefinizione delle funzioni delle immagini da documento e testimonianza a racconto prima letterario e poi cinematografico, con tutti gli slittamenti di senso, i limiti e le potenzialità, che questa ricollocazione comporta.
L’OCCHIO DEL CICLONE, Franco Farinelli
In Afghanistan vengono a contatto l’Oriente e l’Occidente del mondo e il Nord e il Sud del più grande dei continenti: ne risulta una specie di terra di nessuno, di territorio che per molti aspetti funziona, rispetto a ciò cui siamo abituati, da antiterritorio. Secondo i dati più recenti, a volerli prendere per buoni, la cultura nomade è fortemente minoritaria dal punto di vista statistico. Ma non lo è di certo sotto il profilo politico. Ancora oggi con le varie forme dei loro spostamenti gli afghani esprimono in maniera diretta il carattere dell’intero Paese, la cui unità economica prima ancora che politica su fonda proprio sull’integrazione tra il deserto, la steppa e la montagna. Diversamente ad esempio da quella mongola, l’originalità dell’Islam tra le civilizzazioni mobili si fonda sulla capacità di conciliare cultura urbana e cultura nomade. Ma in Afghanistan l’Islam ha semplicemente rinforzato meccanismi già in atto, come avvisa l’antichità e la stabilità delle città più importanti, tutte nate prima dell’arrivo degli Arabi e tutte con il nome del fiume sulle cui rive sorgono. Come recita un proverbio: “a Kabul è meglio che manchi l’oro che la neve”, a segno dell’immediata dipendenza di tutta la vita afghana dal fattore idrico, proprio come in India il padrone del Paese è il monsone, nel senso che dai suoi capricci dipende la pioggia e quindi la vita. Non a caso l’inizio dell’anno afghano corrisponde all’inizio della primavera, al 21 marzo del nostro calendario, cioè all’inizio della fusione del manto nevoso: quasi all’improvviso la terra si copre di una veste verde e brillante, ma prima della fine di maggio la festa finisce ed essa riprende i toni grigi, bruni e gialli di tutti gli altri giorni. Sono i colori del dasht, steppa piatta molto rocciosa sempre battuta dal vento e poverissima di vegetazione: sull’altipiano iranico (di cui per i geografi l’Afghanistan è la sezione orientale) è impossibile allontanarsi davvero dalle montagne, se non per calpestare le pietre, a volte ridotte a sabbia, che ne discendono. E sono le montagne più arcigne del mondo, dominate verso oriente dal nodo orografico dell’Hindukush, il Paropàmiso degli antichi Greci, il complesso di catene da cui l’intero Afghanistan è innervato.
Hindukush vuol dire “la morte degli indù”. Come la contigua catena dell’Himalaya esso è una barriera che separa non soltanto popoli, ma un’intera parte dell’umanità dall’altra: di qui, cioè in Afghanistan, Maometto, di là, in India, Kalì, Shiva e Visnù; di qui il grano, la frutta, le pecore, che sommate alle capre equivalgono per numero ai venticinque milioni di abitanti, di là il riso, l’erba, i bovini; di qui i pastori, e l’organizzazione sociale retta dalle tribù; di là gli agricoltori, i sedentari ordinati dal sistema delle caste. E così come divide i maomettani dagli indù e gli allevatori di pecore, capre e cavalli dai pastori di vacche, e gli uomini dalla carnagione bianca o gialla da quelli di pelle scura, l’Hindukush separa anche l’un dall’altro i cammelli: a nord quello a due gobbe, detto di Battriana perché originario appunto della regione, a sud invece il dromedario a una gobba sola. Oggi ai cammelli si vanno sostituendo i camion, ma il numero delle gobbe rimane decisivo per la comprensione del complicatissimo mosaico culturale afghano, rispetto al quale l’Hindukush svolge un ruolo di divisorio etnico del tutto analogo, per nettezza e perentorietà, al ruolo di spartiacque con cui le sue creste indirizzano, o di qua o di là, il corso dei fiumi: sebbene le lingue ufficiali siano soltanto due, il pashto e il dari che è un dialetto persiano, in Afghanistan si parlano più di trentadue linguaggi, di cui dodici sconosciuti al di fuori dei suoi confini.
Anche in questo caso si tratta di una condizione del tutto originale nel contesto della montagna asiatica. Il cammello a due gobbe è la cavalcatura dei Turchi, nomadi delle steppe fredde e delle montagne continentali dell’Asia centrale. Il suo piede robusto s’adatta bene al suolo roccioso, non teme il freddo ma non sopporta il caldo. Al contrario il dromedario, più alto e dai piedi fragili, soffre molto il gelo. Tali differenze sono state decisive nella storia dell’islamizzazione dell’Asia: i Turchi hanno sistematicamente cercato la montagna, gli Arabi al contrario l’hanno sistematicamente evitata, limitandosi a contornarla. In una terra come quella afghana dove le montagne e gli altipiani dominano, dove le temperature polari delle più alte vette contrastano con quelle dei deserti tra i più aridi al mondo, e dove quasi metà della terra coltivata ha bisogno di irrigazione, lo spostamento di uomini e bestie è una forma spontanea e antichissima, oltre che ineliminabile, di utilizzazione del suolo. Le diversità riguardano il raggio di tali spostamenti, all’interno del rapporto che esiste tra le diverse attività economiche: l’agricoltura, l’allevamento, il commercio, il trasporto. Ed è al riguardo che l’originalità del laboratorio afghano si impone, nel panorama globale, in tutto il suo carattere eccezionale, fondato sull’evoluzione del semi-nomadismo verso il grande nomadismo di tribú come i Pathani, che non appena la neve inizia a fondere salgono sui pascoli intorno a Kabul da Qandahar ad occidente e da Jalalabad ad oriente, ma anche dal bacino dell’Indo in territorio pakistano, in una sorta di continua simbiosi con le economie stabili.
Si tratta del lascito oggi più evidente del processo di vera e propria beduinizzazione cioè nomadizzazione iniziato in epoca medievale e culminato con la catastrofe dell’invasione mongola, e che soltanto nell’ultimo mezzo secolo ha iniziato a segnare il passo. Tipico dell’intero mondo turco-iranico, in Afghanistan tale processo si è spento molto più tardi che altrove, e ha costituito il fondamento della costituzione del moderno stato nazionale afghano. Il che si configura, dal punto di vista della storia dell’occidente ma non solo, come un autentico paradosso, perché beduinizzazione significa trasformazione della popolazione da sedentaria a nomade, oppure (come nel caso degli Hazara) il controllo dei nomadi sull’attività agricola, mentre lo Stato moderno territoriale centralizzato implica invece la stabilità, la fissità al suolo dei cittadini, la staticità appunto.
In Afghanistan, terra dell’incontro tra i nomadi dell’Asia centrale e quelli del Medio Oriente ma Paese fisiograficamente chiuso e semiisolato, lo Stato è nato al contrario, a rovescio rispetto a quanto accaduto altrove. Di qui, prima ancora che per la sua storica funzione di stato-tampone tra Russia ed Occidente, la ragione più profonda dell’interesse che esso continua a suscitare dal punto di vista geopolitico, continuando implicitamente a porre, per la sua semplice esistenza cioè in virtù della sua propria materiale e culturale costituzione, la domanda: un altro Stato è geneticamente possibile? Oppure, ed è lo stesso: gli organismi statali molto più fedeli all’originario modello territoriale moderno sono destinati a mutare? Un dato è certo: più il tempo passa e più il mondo intero è chiamato a modificare l’idea, centrale per la costruzione dell’intera cultura e struttura politica moderne, dell’immobilità dell’abitante statale. Come dire che soltanto ponendo mente a quel che di più diverso anzi esotico esiste rispetto a noi siamo in grado di pensare il nostro futuro: proprio questa è, se non altra, la grande interrogativa lezione dell’esistenza dell’Afghanistan. Di questi tempi davvero preziosa.
INTRODUZIONE / BACKSTAGE
“Invasion Drama” è una mostra fotografica a cura di Laura Andreini, in collaborazione con Forma Edizioni. Un racconto per immagini, scattate dal giornalista Roberto Di Caro, delle guerre in Afghanistan e Iraq dal 2001 al 2009, un diario di viaggio tra speranze, rabbia, rassegnazione, attraverso immagini dal fronte, scritti, reperti e musiche. Negli scatti scorre una quotidianità difficilmente immaginabile: un Afghanistan senza pace da decenni, i mujaheddin al fronte, la resa della roccaforte talebana di Kunduz, i combattimenti contro Al Qaeda in Kurdistan, la frenesia del ritorno alla normalità nell’Iraq dopo la caduta di Saddam, gli attentati a Baghdad. Dietro ogni volto c’è una storia, una ferita, un riscatto. Il tentativo è mostrare anche l’altra faccia di conflitti fatti non solo di kalashnikov e carri armati, ma di persone, vita ordinaria, bambini, donne e uomini in territori distrutti dalle bombe in guerre che sembrano non avere fine. Mettendo a confronto due realtà, Afghanistan e Iraq, facendole dialogare su vari temi, nomadismo, guerra, città, archeologia e altri. Per dar conto delle complessità e contraddizioni di conflitti di cui troppo spesso sfuggono le coordinate, le ragioni, le possibili vie d’uscita. Situazioni irripetibili vissute dal reporter, un lavoro di quasi un decennio sviscerato e racchiuso nello spazio di Rifugio Digitale.
NOMADISMO- AFGHANISTAN
“È un’attitudine del corpo è uno stato mentale: lo leggi nei volti dei profughi che a dorso di cammello rientrano ai loro villaggi, nei tratti dei mujaheddin che vanno irridenti alla battaglia, nell’incedere di donne e bambini nella luce del deserto.
GUERRA- AFGHANISTAN
Al fronte di Kunduz i mujaheddin sparano, uccidono, muoiono, ma è ramadan, nessuno mangia, beve, fuma fino al tramonto. La resa del mullah e di seicento talebani è un semplice cambio di fronte. Von Clausewitz si rivolterebbe nella tomba, ma questa è la loro guerra, non la sua.
TALEBANI- AFGHANISTAN
Prigionieri, gli ultimi che hanno scelto di combattere: ma dalla folla nessuna vendetta, nessun tentativo di linciaggio. Uccisi, gli stranieri di Al Qaeda: ma anche per loro c è rispetto, sguardi senza odio, una coperta a nasconderne il corpo.
VITA QUOTIDIANA- AFGHANISTAN
Quando nasci dentro una guerra infinita non c’è alcuna distinzione con il quotidiano. Si gioca su una carcassa di carro armato, i murali ti mostrano le mine da evitare, sulla linea del fronte le bambine sgusciano il riso messo a essiccare sulla strada.
VOLTI- AFGHANISTAN
Radiosi, di maestre e ragazze di nuovo a scuola dopo cinque anni, Kabul marzo 2002. In festa, dei ragazzini di nuovo liberi di ridere e giocare, Kunduz novembre 2001. In vetrina, di donne senza veli mai viste prima. Puliti, di giovani e vecchi non rassegnati, non assuefatti.
KABUL - AFGHANISTAN
Alla caduta dei talebani, una caotica metropoli di due milioni di abitanti a ridosso delle montagne, file di taxi gialli, il formicolare del commercio, librai tra i segni della distruzione, mendicanti, bazar in riva ad acque puzzolenti. Nel 2005, prime elezioni, le donne al parlamento.
CIVILTà - AFGHANISTAN
I minareti della Musalla, la Moschea del Venerdì, la Cittadella fortificata le cui origini risalgono ad Alessandro Magno. Più volte saccheggiata, distrutta da Tamerlano, fu suo figlio Shah Rukh a fare della città di Herat “la Firenze d’Oriente”, capitale delle arti e del commercio.
ROBERTO DI CARO
Inviato del settimanale L’Espresso, premio Ecole instrument de paix “per un’informazione a difesa dei diritti umani”, ha seguito alcune tra le principali crisi internazionali dei decenni scorsi, Iran, Russia, Ukraina, Caucaso, Turchia, Pakistan, Sudan, Haiti. Nel 2001 il conflitto in Afghanistan sul fronte dell’Alleanza del Nord, nel 2003 la guerra in Iraq e il convulso dopoguerra. Insegna Reportage al master di giornalismo dell’Alma Mater di Bologna.
CURDI - IRAQ
Un popolo, intanto: lingua, tradizioni, usi, costumi, abiti. Fiero e orgoglioso. Rispettoso delle donne. Tollerante. Combattivo. Litigioso al suo interno, è vero. Beffato dalla storia, oppresso dai nemici, tradito dagli amici, anche oggi. E mai riconosciuto da nessuno.
GUERRA - IRAQ
Fratricida. Settaria. Di invasione. Tra potenze straniere su suolo iraqeno. Per abbattere un tiranno, certo, ma senza sapere che fare dopo, come muoversi in una società complessa, come costruire una accettabile democrazia, insomma come vincere la pace.
ICONOGRAFIA - IRAQ
Saddam Hussein, il padre della patria, il condottiero, il vittorioso, osannato sui muri, in mausolei di pietra, persino sugli abiti di moda. In un giorno, abbattuto, cancellato, irriso: un diavolo con gli orecchini, l’asso di picche nel mazzo dei ricercati.
VITA QUOTIDIANA - IRAQ
I dinari iraqeni non valgono niente, si cambiano a peso. Sei dollari per 20 litri di benzina, 100 per un kalashnikov, chiusa per un anno la Borsa. Per strada si vive, si manifesta, si muore negli attentati. Fra controlli e filo spinato.
VOLTI - IRAQ
Di ragazzi precocemente indottrinati al jihad. Di donne che protestano e altre che combattono. Di ragazze in festa per la liberazione di Kirkuk. Di padri e figli e venerabili anziani. E di attrici che nel teatro Rashid, colpito e ancora fumante, recitano Camus.
BAGHDAD - IRAQ
Deserta, nei primi giorni dell’occupazione americana. All’improvviso di nuovo caotica e brulicante di traffici e commerci dal fiume Tigri al “mercato dei ladri”. Le code per ricevere tessere e sussidi. E la distribuzione di acqua potabile, che il mullah sostiene “avvelenata dagli infedeli”.
CIVILTà
Reperti alla mercè dei ladri al museo di Baghdad. Saccheggiata dai predoni Ur, dove nacque la civiltà. Fatti saltare in aria dall’Isis templi e mura di Niniveh, capitale assira, e della seleucide Hatra. A Samarra distrutta da terroristi sunniti la cupola d’oro della moschea sciita di Al Askari.